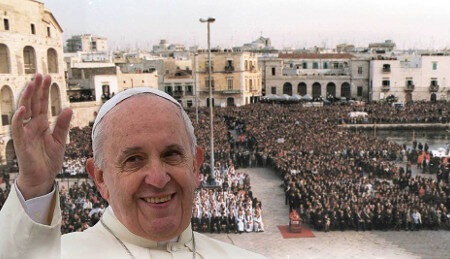EDUCARE NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ E DELLA LIQUIDITÀ
Salva/Stampa la Relazione in PDF
Giovanni Cucci S.I.
Non c’è dubbio che le società occidentali attraversino una crisi di credibilità, una crisi di crescita. Questa paura di crescere può essere resa da una storiella — che riporta il dialogo tra una madre e il proprio figlio — una storiella che ho ritrovato in testi di diversi paesi dell’Europa e proprio per questo mi sembra significativa: «“Su, Filippo, svegliati, sono le 7, la colazione è pronta, i vestiti puliti sono sulla sedia, ti ho spazzolato le scarpe e preparato la cartella: sbrigati, altrimenti arriverai in ritardo a scuola, come al solito”. “Mamma, non voglio più andare a scuola! Mi annoio da morire, le merendine del bar sono disgustose e tutti i bambini mi prendono in giro”. “Smettila di protestare e preparati per uscire. Hai tre buoni motivi per farlo. Primo, perché è tuo dovere; secondo, perché hai 50 anni e terzo perché sei il preside»[1].
Per quanto frutto di immaginazione, questo dialogo è tutt’altro che irreale e insieme all’umorismo finale fa trapelare una triste realtà, una realtà che risulta inedita nella storia delle società umane, anche in Occidente. In questa scenetta sono contenuti molti degli elementi di questo disagio.
La scomparsa del padre
Anzitutto la scomparsa del padre. In questo dialogo, non a caso, egli non solo non è presente, ma non viene mai menzionato. Il padre è il grande assente dalla scena educativa, familiare e culturale occidentale della seconda metà del secolo XX. Qualcuno ha notato che i padri delle nostre società sono partiti per la seconda guerra mondiale e non sono più tornati: in quella guerra, e nel periodo successivo, essi hanno trovato la morte fisica, ma soprattutto simbolica, la morte del significato del loro ruolo. Un padre che nella riflessione culturale (penso soprattutto alla psicologia dello sviluppo e all’antropologia culturale) è legato all’autorità e alla dimensione religiosa.
Per questo la sua scomparsa cade parallela alla scomparsa progressiva della dimensione religiosa e dell’autorità in genere dallo scenario culturale e immaginifico dell’Occidente, come si è già avuto modo di notare in altra sede[2].
Ma la scomparsa del padre intacca fortemente anche il ruolo della madre, come si vede dalla diade perversa che emerge da quella storiella. Il ruolo tradizionalmente tenuto dai genitori va sempre più scemando per dare origine a quella che Ron Taffel chiama «la seconda famiglia», dove tutti stanno sullo stesso piano di età, autorità, mentalità, tutti hanno i medesimi gusti, tutti si vestono e si comportano allo stesso modo, e dove regna “la tirannia del freddo”[3]. Il risultato è l’accentuato rischio verso comportamenti e relazioni di tipo pedofilo (non dimentichiamo che il 70-80% dei casi di pedofilia si riscontra in famiglia): «Una società che non ha più genitori e figli ma dei fratelli e dei compagni diventa progressivamente perversa […]. La società fraterna non è possibile che nella misura in cui s’inscrive in una simbolica paterna. Senza padre non ci sono fratelli. La società dei compagni o degli amici assomiglia allo sradicamento della filiazione paterna che rifiuta il padre»[4]. Adulti e ragazzi diventano in questo modo succubi delle medesime fragilità affettive, delle medesime paure e insicurezze, dei medesimi problemi con l’alcool, la droga, l’aggressività, la sessualità. Come potrebbe un genitore iniziare il proprio figlio alla realtà, quando si trova egli stesso incapace di affrontare in modo maturo e responsabile questi problemi?
Una diade perversa
La scenetta sopra ricordata mostra una relazione possessiva e a senso unico tra madre e figlio, che formano una diade perversa, conducendo alla crisi, oltre che del padre, della stessa maschilità. Il bambino rischia così di essere ben presto trattato come un mini-adulto, soprattutto se cresciuto da un genitore single: in questo caso sarà forte la tendenza a riversare su di lui attese e aspettative che egli dovrebbe invece rivolgere al proprio partner. Ciò dà origine a quelle perverse diadi in cui il figlio o la figlia sono chiamati a diventare rispettivamente «vicemarito» o «vicemoglie» del proprio genitore. In tal modo si impedisce loro di vivere la tappa infantile e di figliolanza della propria vita, due condizioni essenziali per la maturità psichica, cognitiva e affettiva. I figli si trovano così schiacciati dai bisogni dei genitori, alla stregua di un giocattolo chiamato a compensare le carenze degli adulti. Come confessava una ragazza sconsolata: «Mio padre non fa altro che correre dietro alle mie amiche e poi chiede di potersi confidare con me»[5].
Alcuni sintomi allarmanti di questa instabilità si possono ad esempio riscontrare nel continuo aumento, in bambini e adolescenti, di disturbi dell’alimentazione e del linguaggio, due aree in cui la dimensione affettiva e di comunicazione è fondamentale. Questi due disturbi dicono di un disagio che non sembra ancora essere stato colto nella sua gravità a livello di cura e trattamento psicologico, ma che evidenzia un notevole senso di precarietà, «un senso di impotenza di fronte ai problemi della vita», come si esprime H. Bruch parlando dell’anoressia[6].
La scomparsa della coppia padre-madre si accompagna a una soffocante attenzione nei confronti di un figlio sempre più «mammone», una situazione che sembra ancora più accentuata nel nostro Paese. Come in quella storiella, egli sa quello che non vuole («andare a scuola»), ma non sa quello che vuole, ha smarrito il desiderio profondo, quello per cui vale la pena rischiare e sacrificarsi. Questa è a mio parere la sconfitta educativa più grave, l’atrofia del desiderio, per lasciare il posto a una miriade di bisogni più o meno effimeri.
Un approccio emotivo all’esistenza
Questo povero preside non vuole andare a scuola perché non ne ha voglia. Sappiamo come le emozioni, qualora non vengano adeguatamente educate e integrate con gli altri aspetti della personalità, possano rendere problematico il processo della valutazione e della decisione, rimandando scelte importanti ma anche attuando comportamenti irresponsabili e pericolosi, per sé e per gli altri. La forza delle emozioni è anche la sua debolezza: esse sono immediate, travolgenti, ma di breve durata, incapaci di giungere alla profondità delle cose, fermandosi all’impressione del momento. Questa tendenza è oggi sempre più diffusa, specie in sede culturale, di comunicazione, dove si utilizzano frasi ad effetto che possono con facilità manipolare il consenso anche su problemi gravi e delicati (come in materia di bioetica e sessualità).
È un approccio che rifugge la fatica del pensare, del confronto, dell’approfondimento, soprattutto di mettere in conto un opportuno lasso di tempo per formarsi un’idea adeguata della complessità dei problemi in gioco; in questa modalità di approccio, di nuovo, non si nota una grande differenza tra gli adulti e i bambini: «Il pubblico non vuole la complessità, le sfumature, la riflessione sui grandi problemi, ma uno slogan semplice, ben definita, riconoscibile come i personaggi e le scene dei teleromanzi»[7].
La tendenza alla semplificazione, di per sé legittima, rischia di andare a scapito della profondità e della complessità delle problematiche in gioco, finendo per procedere per etichette estreme di bianco/nero, incapaci di cogliere la realtà e i dettagli. Lo scrittore Alfonso Beria di Argentine, che fu un fine osservatore della società italiana, nella sua duplice veste di magistrato e giornalista, parlava paradossalmente di «elogio della mediocrità» come necessaria via di accesso a una realtà che, a differenza della fantasia, non è riducibile a slogan, a contrapposizioni totali: «Mi colpisce sempre più l’incapacità di tanti, giovani, ma non solo, ad accettare le tensioni intermedie. Un matrimonio non può essere faticoso, o è meraviglioso o è da rompere; un lavoro non può essere faticoso, o è gratificante o è da cambiare; un’amicizia non può avere passaggi difficili, o è totale o diventa freddezza e odio»[8].
In questo modo si assiste a un ulteriore paradosso: la precarietà e l’instabilità delle emozioni portano a rimandare le scelte importanti, ma nello stesso tempo si mettono in atto con facilità comportamenti che possono portare alla morte, o a infermità permanenti per sé e per altri. Lo testimonia l’aumento impressionante di incidenti stradali e di atti di violenza dovuti all’abuso di alcool, di stupefacenti, di notti insonni. Si pensi ancora alle gravi conseguenze di comportamenti sessuali spregiudicati: tutto viene compiuto senza una riflessione circa la reale portata di queste azioni, del rischio che implica, dei possibili danni provocati, ma soprattutto senza che la persona si trovi veramente presente in ciò che ha fatto. «Non volevo», «non ci pensavo», «non ero in me», sono le giustificazioni più ricorrenti. L’emozione come criterio conoscitivo e valutativo di scelta può portare a conseguenze molto pericolose. L’accoglienza della fragilità e del limite, caratteristiche della corporeità, è dolorosa ma essenziale per realizzare qualcosa di significativo nella vita: «Quando non si accetta la fatica di un matrimonio, di un lavoro, di un’amicizia, di un’impresa, significa che non si capisce che tutto nella vita è processo oggettivo e non solo esperienza soggettiva […]. Se invece di essere attenti all’oggetto siamo tutti centrati su come soggettivamente ed emotivamente sentiamo l’esperienza di noi in quell’oggetto, allora il metro di giudizio e di comportamento ricade nella sfera soggettiva e scivola facilmente nel dilemma dell’avere tutto nella pienezza o nel rinunciare a tutto nella disgregazione»[9].
E in effetti la disgregazione, la morte, a livello individuale come sociale, è un altro segnale allarmante trasmesso frequentemente dalla mentalità liquida.
L’attrattiva della morte
I dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità mostrano un cospicuo aumento del suicidio in genere negli ultimi 50 anni — più del 60% —, ma per quanto riguarda gli adolescenti esso è cresciuto del 400%. Negli Stati Uniti, ogni 90 minuti un adolescente si toglie la vita[10].
Per quanto riguarda l’Italia, anche se le percentuali circa depressioni e suicidio non raggiungono gli incrementi registrati da altri Paesi europei (come Lussembrugo, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Francia), i dati restano ugualmente preoccupanti. Nel corso di 10 anni (1972-1982) il suicidio fra i maschi nell’età dello sviluppo (15-24 anni) è aumentato del 33,3%; ma quello che soprattutto impressiona è la sua crescita inarrestabile, al punto da essere diventata ormai la prima causa di morte tra i giovani[11]. In media i ragazzi hanno una percentuale di morte tripla rispetto alle ragazze. Il discorso diventa ancora più grave se si considerano i tentati suicidi (dove le ragazze registrano una percentuale doppia rispetto ai ragazzi) e l’andamento generale del fenomeno nel corso degli anni.
Ciò che preoccupa è il diffondersi massiccio di quelle che M. Benasayag e G. Schmit (un filosofo e uno psichiatra) chiamano «le passioni tristi», alla base dell’aumento preoccupante di richieste di aiuto psicologico da parte di giovani e giovanissimi in Francia negli ultimi anni. Esse sono il segno di una grave sofferenza interiore, di un disagio profondo e complesso. Le «passioni tristi» (come le chiamava Spinoza) esprimono una sofferenza esistenziale, «non sono il dolore o il pianto, ma l’impotenza, la disgregazione e la mancanza di senso, che fanno della crisi attuale qualcosa di diverso dalle altre […], si tratta di una crisi dei fondamenti stessi della nostra civiltà»[12].
L’aspetto più grave del proliferare delle passioni tristi è che sono la conseguenza della paura del futuro (mentre la giovinezza è strutturalmente aperta al futuro): «La psiche è sana quando è aperta al futuro (a differenza della psiche depressa tutta raccolta nel passato, e della psiche maniacale tutta concentrata sul presente) quando il futuro chiude le sue porte o, se le apre, è solo per offrirsi come incertezza, precarietà, insicurezza, inquietudine, allora “il terribile è già accaduto”, perché le iniziative si spengono, le speranze appaiono vuote, la demotivazione cresce, l’energia vitale implode»[13]. E al futuro è legata la capacità progettuale della vita, un disegno capace di darle significato.
Le passioni tristi reclamano un valore che si è smarrito perché ritenuto ininfluente per la vita. In questo senso la depressione giovanile è stata definita «la malattia dell’ideale»[14]. Presentare l’ideale, e interiorizzarlo, è il compito dell’educazione, e richiede tempo, gradualità, soprattutto il confronto con tematiche impopolari e scomode, come la frustrazione, la norma, la mancanza di gratificazioni immediate e la non visibilità dei frutti. Richiede soprattutto la presenza degli educatori, di figure capaci di trasmettere il valore con la loro vita.
Ma per quale motivo si registra un aumento così rilevante dei comportamenti di morte, in particolare in una fascia di età che dovrebbe essere la più aperta alla vita?
Secondo alcuni studiosi, alla base di questo impressionante incremento c’è un aspetto proprio della liquidità, il considerare ogni scelta come provvisoria, reversibile: la categoria del definitivo è scomparsa. In tal modo anche la morte, non viene considerata come qualcosa che è per sempre, ma come una dimensione per molti versi attraente, da «gioco elettronico», cui si guarda con curiosità, specie se la propria condizione è caratterizzata dalla noia, dal vuoto, dalla mancanza di interessi e impegni.
Anche la cultura virtuale contribuisce a questa valutazione; è una conseguenza della mancata attenzione alla corporeità. Molti ragazzi non hanno mai visto un cadavere, in particolare in occasione della morte dei propri cari. In tal modo le morti reali vengono cancellate in fretta: «Non aver mai vegliato un cadavere è una metafora di come la società del narcisismo ha rimosso a livello educativo e culturale la malattia e la morte»[15].
È una rimozione che ci accompagna da tempo. A partire dal sec. XVIII in avanti il tema della morte viene posto in “quarantena”, in una sorta di limbo, anche se in tal modo la morte, come ogni realtà repressa, fa sentire in modo ancora più inquietante la propria suggestione. È significativo che le grandi battaglie culturali odierne in occidente abbiano come tema la morte (cfr. ad es. i dibattiti sull’eutanasia)[16].
C’è una preghiera latina, mai stata tradotta in italiano, e non più recitata: a repentina et improvisa morte libera nos Domine. Noi oggi diremmo il contrario: per favore dacci una morte improvvisa e repentina. Come si sente talvolta a dei funerali commentare: “però, che fortuna, è morto senza neanche accorgersi”. Per gli antichi questa era la morte peggiore, è come essere chiamati a sostenere un esame senza essersi minimante preparati. E voi capite che qui c’è in gioco ben più che un esame. È significativo che la gran parte del vangelo sia dedicato alla morte di Gesù, un evento cui si prepara accuratamente (“i vangeli sono un racconto della passione con una lunga introduzione” Martin Kehler). Anche la moda della cremazione, dietro motivazioni economiche ha una mascherata forma di igiene finale, di cosmesi. Che cancella la memoria del defunto, della propria morte, della stessa malattia. Se si entra in una farmacia, sembra di entrare in un negozio di giocattoli: tutto è soft e ovattato. Ma come ricorderebbe Freud, quanto più si reprime, una cosa tanto più essa si fa sentire in maniera inquietante, nascosta, fino ad avvelenare l’intera vita.
A questo proposito, si può sottoscrivere senza troppe riserve la denuncia di Tahca Ushte, sciamano dei Sioux: «Voi bianchi diffondete la morte. La comprate e la vendete. Con i vostri deodoranti i vostri profumi puzzate di morte, ma avete paura della realtà. Avete paura di guardare in faccia la morte. L’avete resa igienica, l’avete impacchettata, l’avete spogliata della sua dignità. Noi indiani pensiamo spesso alla morte. E anch’io. Oggi per esempio sarebbe un giorno buono per morire, un giorno non troppo caldo e non troppo freddo. Un giorno buono per salutare gli amici, per dire ciò che provo per loro. Un giorno per un uomo felice per arrivare alla fine del suo cammino. Un uomo giocoso con molti amici. Altri giorni non sono così buoni. Essi sono riservati agli egoisti e ai solitari, a coloro che riescono solo con difficoltà a separarsi da questa terra. Per voi bianchi ogni giorno sarebbe probabilmente un cattivo giorno»[17].
È interessante la conclusione: la rimozione della morte rende cattivi gli altri giorni… spegne il gusto di vivere. È un altro grande cambiamento culturale che ha conseguenze rilevanti in ordine alla liquidità del vivere. Ma soprattutto è triste che questo avvertimento ci giunga da altre culture, come se la tradizione cristiana su questo fosse stata del tutto cancellata.
Il trionfo del narcisismo
Altre motivazioni di questo mutato atteggiamento verso la morte possono essere ritrovate nel modello narcisistico ad esso sottostante, un modello che non tollera sconfitte, difetti, incapacità. Questo stile di personalità, se prevalente nel corso dello sviluppo, riflette una preoccupante fragilità dell’io, l’incapacità di affrontare situazioni non gratificanti, vissute come smentita al valore di sé. Perciò ogni piccolo ostacolo o insuccesso — un voto scolastico, la presa in giro da parte dei coetanei, il «no» della persona amata, il rimprovero del genitore — rischia di essere vissuto come una catastrofe globale per la stima di sé, con conseguenze tragiche. Uccidersi diventa così un modo di fuggire dal dolore e dalla vergogna.
È per questi motivi che l’aumento del narcisismo va considerato come un fenomeno preoccupante dell’accresciuta fragilità delle giovani generazioni, che vedono con terrore l’assunzione di responsabilità, proprie della vita adulta. La tappa dell’adolescenza è indubbiamente predisposta a questo stile di personalità; essa può tuttavia assumere nel corso dello sviluppo una modalità sana nel momento in cui è provvisoria, aperta alle tappe successive della vita. Quando invece il narcisismo tende a permanere e a diffondersi con il trascorrere del tempo, diventa una spia sintomatica di un disagio e di una carenza educativa: esso indica che la persona non è in grado di guardare in faccia alla realtà nei suoi aspetti meno attraenti, ma non per questo meno importanti e profondi. Questo stile di personalità tuttavia è ormai diventato talmente diffuso e praticato che gli psicologi e psichiatri statunitensi lo hanno «legalizzato», cancellandolo dall’elenco dei disturbi mentali nella quinta edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, pubblicato nel 2013.
Una categoria recente
L’adolescenza e la giovinezza considerate in se stesse, come una specifica fase della vita, sono una categoria recente, una «invenzione», come direbbe John Savage che risale alla fine dell’800. Nel 1942 il sociologo Tim Parsons introduce il temine «cultura giovanile», per definire lo stile di vita degli americani di quell’epoca, mentre nel settembre 1944 viene lanciata la rivista Seventeen, interamente dedicata ai ragazzi e alle ragazze di quella fascia di età.
Dal dopoguerra in poi, mentre il padre scompare, il teenager diventa la categoria vincente, sempre più imitata anche da persone che non appartengono a quella classe anagrafica, ma che rifiutano di accettare il trascorrere degli anni. Essere teenager è un ideale di vita, come emerge dalla lettera di questa ragazza: «Adoro avere diciassette anni. Vorrei poter rimanere a lungo a questa età. Diciassette anni è il punto perfetto tra quella strana condizione chiamata “adolescenza”, che significa che devi andare da qualche parte, e l’età adulta, che significa che puoi solo scendere»[18].
Il teenager cessa ben presto di essere una fascia di età biologica per diventare una mentalità, una categoria psicologica consacrata dalla letteratura, che è sempre un rilevatore potente di una mentalità. Tutti conosciamo la vicenda del romanzo di James Barrie Peter Pan il bambino che non voleva crescere pubblicato nel 1911. Come spesso accade nella storia, un racconto può raffigurare una situazione e annunziare una nuova epoca. Il rifiuto di crescere diventa così ben presto anche un fenomeno psicologico e sociale di notevoli dimensioni.
L’esaltazione dell’adolescenza come modello di riferimento, rimane tuttavia una sconcertante novità nella storia umana. Margaret Mead, nelle sue ricerche ormai divenute classiche, confrontando ragazzi e ragazze di società e popolazioni diverse, giunge alla conclusione che, quando non viene enfatizzata da una società, l’adolescenza non si presenta come problematica e inquieta e il ragazzo/a giungono con relativa facilità alla fase adulta. Non è vero che l’adolescente sia strutturalmente inquieto: lo è solo in alcune società e culture, e anche in esse il fenomeno non è affatto uniforme. Esso diventa più appariscente nelle famiglie in cui vengono accentuate l’emotività (con la tendenza a valutare problemi e difficoltà in modo drammatico e superficiale) e la proprietà (la «mentalità dell’avere», di cui parla E. Fromm), e nelle quali è presente una notevole ma disorientante ricchezza di possibilità, poste tuttavia su di un medesimo piano di importanza, senza un criterio unificatore, senza una intelligenza in grado di valutarle. La Mead riteneva così che «il guaio degli adolescenti americani è un eccesso di scelte, un eccesso di pressioni e un contatto troppo scarso coi fenomeni del mondo reale, come la nascita e la morte»[19]. E scriveva questo nel 1928…
Più la società è complessa e stratificata, «liquida» come si usa dire oggi, più l’adolescenza si presenta come una tappa difficile, prolungata e problematica della vita. «Problematica» soprattutto perché stenta a trovare una sua identità e una terminazione. Nessuno oggi pone più al ragazzo/a la classica domanda: “cosa vuoi fare da grande?”.
L’adulto non è più il modello di riferimento dell’adolescente, ma è semmai il contrario: «Restare giovani diviene l’ideale esistenziale pensando di avere sempre aperte a tutte le età le strade davanti a sé»[20]. Abbiamo così la figura dell’adulto che si comporta da bambino, da persona immatura, cioè incapace di stabilità, di essere responsabile di sé e di altri. Come in un gioco perverso, le parti vengono scambiate, rovesciando pericolosamente il significato della sconfitta edipica: «Se si guarda attentamente al contenuto dei programmi televisivi, salvo rare eccezioni, gli adulti non prendono seriamente il loro lavoro, non allevano bambini, non fanno politica, non praticano alcuna religione, non rappresentano alcuna tradizione, non hanno capacità di pensare al futuro o di formulare seriamente dei programmi, non sono capaci di parlare a lungo, e non sanno mai evitare atteggiamenti degni di un bambino di otto anni»[21].
Non a caso l’episcopato italiano ha scelto come tema di fondo per la pastorale del decennio 2010-2020 la questione educativa, individuando in essa una problematica decisiva per il futuro del nostro paese, minacciato da un malessere sempre più diffuso che ha alle sue radici «il ripiegamento su di sé, la frammentazione e il vuoto di senso»[22]. Si tratta di un compito che deve essere continuamente aggiornato per poter rispondere alle sfide e alle problematiche del nostro tempo.
È infatti nella capacità di attendere a questo impegno fondamentale che si può riconoscere lo stato di salute di una nazione e di una civiltà, come ha anche ricordato Benedetto XVI, parlando a questo proposito di una vera «emergenza educativa»: «A differenza di quanto avviene in campo tecnico o economico, dove i progressi di oggi possono sommarsi a quelli del passato, nell’ambito della formazione e della crescita morale delle persone non esiste una simile possibilità di accumulazione, perché la libertà dell’uomo è sempre nuova e quindi ciascuna persona e ciascuna generazione deve prendere di nuovo, e in proprio, le sue decisioni. Anche i più grandi valori del passato non possono semplicemente essere ereditati, vanno fatti nostri e rinnovati attraverso una, spesso sofferta, scelta personale»[23].
Da qui, insieme, l’urgenza e la grande difficoltà di un tale compito. Si possono precisare alcuni punti in proposito.
L’importanza decisiva della famiglia e i riti di passaggio
L’essere umano non è in grado di svilupparsi senza un ambiente favorevole, cioè all’insegna del senso, dell’ordine, della fiducia e della stabilità. Compito dei genitori è predisporre questo habitat fondamentale, capace di dare il benvenuto al nuovo arrivato: «Non può esserci sviluppo e maturazione psicologica se non c’è la fede nell’ordine. L’inclinazione che l’uomo ha per l’ordine si fonda su una sorta di fede o di fiducia che, in fondo, la realtà sia “in ordine”, che “tutto vada bene”, che sia “come dovrebbe essere” […]. Il ruolo che un genitore si assume non è solo quello di rappresentare l’ordine di questa o quella società, bensì l’ordine in sé, l’ordine che regge l’universo e che ci persuade alla fiducia nella realtà»[24].
Da qui lo stretto legame della relazione genitoriale con la dimensione religiosa dell’esistenza. La fiducia acquisita nell’ambito familiare abilita alla capacità di vivere relazioni stabili, ad affrontare difficoltà e frustrazioni, e risulta decisiva anche in ordine allo sviluppo morale e religioso, alla relazione con un Dio che, nella tradizione biblica, si presenta come un Padre che ama i suoi figli di affetto materno: «Chi ha ereditato dai suoi genitori e nella cerchia familiare la fiducia originaria considera il mondo attorno a sé con gli occhi della fiducia: non ha timore di “rischiare” la propria vita, ha voglia di mettere alla prova le sue capacità. Il suo sentimento di fondo è dominato da una profonda fiducia di poter contare sugli uomini, di potersi fidare in tutta semplicità dell’essere umano. Infine questa fiducia originaria ha anche una componente religiosa: nella sicurezza dell’uomo risplende qualcosa della fedeltà di Dio che ci sostiene e sul quale possiamo contare»[25].
Compito fondamentale dei genitori è anche di attuare i riti di passaggio, che consentono al ragazzo/a di spezzare la possibile diade perversa genitore-figlio e di entrare nel mondo della vita. I riti sono costituiti da gesti e cerimonie anche estremamente semplici (come l’investitura della toga per il ragazzo romano, un periodo trascorso fuori casa per alcune società africane come lo Zambia e il Sudafrica, il cerimoniale ebraico del Bar Mitzvah), compiuti al cospetto di una comunità e accompagnati da un adulto. Il messaggio fondamentale che questi gesti hanno trasmesso nel corso dei secoli è che si deve entrare in una nuova fase della vita, che presenta nuove caratteristiche, in maniera irreversibile.
Di queste iniziazioni non è rimasto quasi più nulla nelle odierne società occidentali, dove al massimo si riscontra il raggiungimento di alcuni traguardi della vita civile (il conseguimento della patente, della laurea, della possibilità di votare). Gli stessi sacramenti dell’iniziazione cristiana difficilmente vengono colti con questo significato, come attesta la sempre più diffusa disaffezione e abbandono della pratica religiosa (piuttosto che il loro consolidamento), una volta che vengono impartiti.
Ma i cerimoniali rimangono indispensabili per la vita, in modo particolare nella fase della crescita. Per questo essi non possono essere semplicemente aboliti o dimenticati da una cultura: essi riappaiono sotto forme inquietanti, diventando celebrazioni di morte.
I riti infatti non possono essere cancellati dall’immaginario di una società, o della vita di un uomo, perché hanno ad oggetto l’aggressività, la sofferenza e la morte, in altre parole l’essere umano nella sua verità e fragilità, espresse concretamente dalla corporeità che consente di fare esperienza di realtà, di differenziarla da sogni e fantasie, perché introduce nella dimensione della temporalità con il suo carattere di irreversibilità (che cosa meglio del nostro corpo è in grado di esprimere concretamente la crescita e l’invecchiamento?).
Quando vengono disattesi, i riti di iniziazione non scompaiono, ma piuttosto impazziscono, dando origine alle derive del «branco», segno dello stadio primitivo dello sviluppo, incapace di gestire le molteplici dimensioni della corporeità. Le violenze delle baby gang, il bullismo maschile e femminile, gli stupri di gruppo, lo sballo del sabato sera, i comportamenti sessuali a rischio, l’assunzione di droga in gruppo, l’attrazione verso l’horror e il macabro, le pratiche dei piercing, delle trafitture, dei tatuaggi sono riti di iniziazione impazziti, sono richieste degenerate di prendere contatto con la dimensione della corporeità, della relazione, dell’aggressività, del pericolo, della morte, ma senza che vi sia più un adulto o una comunità in grado di accompagnarli.
Questi gesti non possono essere alternativi ai riti di passaggio, perché non vi è una autorità, una comunità in grado di accogliere e ratificare queste richieste: «Per risultare accettabile agli occhi della comunità, il rito di passaggio deve fondarsi, più che sui suoi aspetti concreti, su valori simbolici che invece mancano drammaticamente alle pratiche contemporanee di marchiatura fisica»[26].
La mancata attenzione ai riti di iniziazione ha tra le sue conseguenze anche l’impoverimento dell’immaginazione e della capacità di affrontare in modo creativo e stimolante le difficoltà della vita. Il rito poteva accoglierli perché li poneva in relazione a Dio e alla sacralità della vita; questo era il significato del gesto compiuto dal padre di strappare il bambino dalle braccia della madre (che fino a quell’età era il punto di riferimento peculiare) per elevarlo al cielo, un gesto con cui egli riceve la conferma della propria identità: «Il significato di questo gesto è chiaro: si consacrano i neofiti al Dio celeste»[27].
Questa sacralità è stata ugualmente applicata dalle società alla misurazione del tempo, come passaggio da uno stadio all’altro, che mostra una sequenza irreversibile, sempre in avanti. Per restare al contesto dell’Europa cristiana, che a sua volta riprende e integra la tradizione pagana, le stagioni vengono associate a un significato sia economico che religioso (come attesta la celebrazione delle Quattuor tempora), mostrando un progresso nel quale il fedele si trova invitato a entrare: così la primavera è legata alla Pasqua, l’estate alle festività di san Giovanni (nascita e morte), l’autunno a san Martino e l’inverno al Natale. Tutte cose che sembrano oggi quasi da museo, eppure esse celebrano il ritmo dei tempi e delle stagioni in cui si snoda e sviluppa la vicenda umana, con le azioni che scandiscono le sue varie tappe, come la nascita, il lavoro, il matrimonio, la generazione, la morte. Questa caratteristica «sequenziale» della celebrazione è presente in tutti i riti conosciuti: essi ripropongono in forme diverse la tipologia propria del rito di passaggio[28].
Anche se relegata ai musei la consapevolezza della temporalità rimane indispensabile per la vita: crescere significa rinunciare alle caratteristiche dell’età precedente, è un punto di non ritorno. Ciò viene espresso simbolicamente dalle tradizioni letterarie mediante la proibizione di voltarsi indietro una volta intrapreso il cammino, una tentazione tanto suggestiva quanto mortale. Si pensi al brano della Genesi in cui Lot e la sua famiglia, se vogliono sfuggire alla distruzione, devono lasciare la città di Sodoma senza fermarsi, o guardare indietro: la moglie di Lot non resiste alla curiosità, si volta e diventa una statua di sale (cfr Gen 19,15-26). Allo stesso modo, nella mitologia classica, Orfeo, dopo essere riuscito a riportare dagli inferi l’amata sposa Euridice, contrariamente alle avvertenze di Ade e Persefone, si volge a guardarla prima di essere uscito, e la vede così dissolversi da lui, per sempre (cfr Eneide, IV, 485-503).
Il messaggio che ci giunge, da fonti diverse, è concorde: se vuoi vivere, devi proseguire nelle tappe del tuo cammino, vincendo l’illusione di fermarti o volgerti indietro, credendo di avere sempre di fronte a te, intatte, tutte le possibilità a disposizione. È il definitivo oggi disatteso con conseguenze pesantissime, come si è visto parlando del suicidio giovanile. Il passaggio a un’altra fase della vita ha un carattere definitivo: proprio per questo esso va preparato con cura. Con le parole di Gesù, una volta messo mano all’aratro non è più possibile tornare indietro, se si vuole entrare nel Regno di Dio (cf. Lc 9,62). Ignazio prevede 2 anni di tempo per il novizio, chiede la conferma e poi non ci pensa più. Altrimenti potresti stare tutta la vita a soppesare i pro e i contro.
Il ruolo indispensabile del padre
La psicologia dello sviluppo riconosce che il ruolo del padre diventa sempre più importante a partire dai sette anni di vita del bambino, considerato come il tempo del suo ingresso nel mondo. Fino a quell’età la madre rimane il punto di riferimento predominante, anche se in realtà entrambi i genitori restano fondamentali per la differente specificità del loro intervento, per l’aiuto vicendevole che sono chiamati a darsi nelle diverse fasi della vita dei figli.
Se si insiste in modo particolare sul padre non è certo per sminuire il ruolo e l’importanza della madre, ma perché il compito della figura educativa paterna è stato gravemente messo in discussione nel corso del secolo XX, fino a teorizzarne la scomparsa. Ciò che non è invece accaduto per la madre, la cui rilevanza non è mai stata contestata.
La psicologa Chana Ullmann riconosce in particolare tre funzioni, non esclusive, ma certamente specifiche, del padre, per un corretto sviluppo del bambino: esprimere la norma, proteggere, rendere possibile la sconfitta edipica[29].
Il compito del padre 1) Esprimere la norma
Il confronto con la norma diventa per il bambino soprattutto confronto con una figura salda, capace di autorità e quindi di rassicurazione circa le sue paure più profonde, soprattutto quelle di essere abbandonato a se stesso. Egli scopre così anche il suo potere, anzitutto sul proprio comportamento, che può essere modificato e migliorato. La norma, accompagnata dall’affetto, consente così al bambino/a di esprimere il meglio di sé, imparando a padroneggiare la sua aggressività, a indirizzarla verso gli ostacoli e le difficoltà della vita, generando un senso di soddisfazione e di fiducia; questa fiducia, a sua volta, consentirà in seguito di vivere relazioni stabili all’insegna della stima e della donazione di sé.
Quando non si fa esperienza della norma, il rischio può essere l’autismo o il narcisismo, l’incapacità strutturale di riconoscere il valore e l’importanza dei limiti, dei confini che stabiliscono l’identità, consentono di far emergere quelle capacità a partire dalle quali è possibile realizzare qualcosa. Senza limiti riconosciuti ed accettati, c’è il rischio di rifugiarsi in una fantasia onnipotente, dove tutto è ugualmente accessibile perché immaginato, «finto», e di sfuggire così alle situazioni reali. Purtroppo per molti adulti il tema del limite, del «no», è rimasto un problema irrisolto, non integrato, su cui nutrono parecchi dubbi che riaffiorano nel momento in cui sono chiamati a svolgere un compito educativo. Da qui il rischio di dimissionare tale compito, trattando il bambino come un mini-adulto; oppure di esercitare un autoritarismo estremo, in cui la violenza arbitraria copre i dubbi e le profonde insicurezze.
Acquisire il senso della dipendenza — in altre parole, la sconfitta del narcisismo — aiuta a prendere contatto con la propria verità creaturale e a viverla in pienezza, imparando in questo modo anche ad essere comprensivi verso le fragilità e debolezze altrui, come nel fenomeno sempre più diffuso del bullismo: «Negare qualsiasi dipendenza porta a diventare autoritari, se non addirittura prepotenti. I prepotenti, solitamente, hanno paura di trovare qualcuno più forte di loro e di poter ricevere quello che loro stessi sono abituati a dispensare»[30].
Questi elementi, pur importanti, non vanno tuttavia intesi nel senso di una causalità determinante. Ricerche compiute sulle conversioni religiose riscontravano percentuali maggiori proprio in persone che avevano alle spalle relazioni problematiche e conflittuali a livello familiare, e una stima di sé molto bassa. Tutto questo non ha impedito una differente scelta quando si è avuta la possibilità di conoscere figure di riferimento positive: si pensi in proposito al caso di sant’Agostino[31].
2) Proteggere
Il secondo fondamentale compito del padre è di proteggere il figlio/a nel suo ingresso nella realtà esterna e di infondere fiducia, in modo che possa affrontare e superare difficoltà confidando nelle proprie capacità. La figura di un padre forte ma benevolo protegge soprattutto da due pericoli: associando autorità e bontà, egli può mostrare al bambino il significato presente nelle cose; in secondo luogo insegna a riconoscere e gestire la propria aggressività. È la funzione di contenimento (holding) fondamentale in questa tappa di vita, che il genitore è chiamato ad assicurare, presentandosi come un esempio di autorità ma anche di pazienza.
Nell’Odissea Ulisse può essere riconosciuto come padre solo quando, al termine del poema, il figlio lo vede imbracciare l’arco, con fare dimesso ma deciso: «Sembra che Omero abbia pensato ai nostri tempi e ci abbia avvertiti: il padre non scompare mai del tutto. Ma non crediate di ritrovarlo nei maschi rumorosi: quelli sono i Proci, gli eterni non-adulti. Se qualcuno invece è umile, paziente, potrebbe essere lui, sopravvissuto a guerre e tempeste»[32]. L’arco può simboleggiare il ruolo e il compito del padre, che non è delegabile; e difatti nessuno dei proci è in grado di maneggiarlo, perché non ne hanno l’autorità. Ma il padre di cui qui si parla non è affatto il padre-padrone che ha caratterizzato le nostre società degli ultimi due secoli, conducendo infine al suo rifiuto e allontanamento. Ulisse infatti, precisa Omero, maneggia l’arco come un musicista accarezza la sua arpa, associando con questo gesto le due caratteristiche essenziali del padre: la forza e la dolcezza. Solo quando è in grado di unire in sé queste due virtù, l’autorità e la tenerezza, Ulisse può nuovamente tendere il suo arco, e mettere fine alla «notte dei proci»[33].
3) La sconfitta edipica e la dimensione religiosa
Questa intuizione di Freud circa l’importanza del ruolo paterno in ordine allo sviluppo del senso religioso, nel bene come nel male, per quanto legata alla sua personale esperienza, è stato ampiamente confermato dalla successiva ricerca psicologica. Un’indagine compiuta su un campione di giovani che si erano riavvicinati alla vita di fede e alla pratica religiosa, mostrava come l’80% dei convertiti avevano avuto una relazione molto difficile con il proprio padre (contro il 23% dei non convertiti), da essi descritto come aggressivo e violento (questo elemento costituisce il dato più alto dell’indice di negatività nella relazione), assente, passivo, inaffidabile o urtante. Un terzo del campione studiato non aveva mai conosciuto il proprio padre biologico dall’età di 4-5 anni, una percentuale tre volte più alta della media USA del 1970 (9%)[34]. Solo il 18% dei convertiti parlava in termini positivi della propria relazione con il padre (contro il 47% dei non convertiti). Il problema con il padre si presenta con la medesima frequenza negli uomini come nelle donne, mentre non si mostravano differenze significative circa la relazione con la madre. L’influenza affettiva, negativa, tribolata o assente, del padre emerge con insistenza nei racconti e indica che «questa relazione spesso gioca un ruolo importante nel tipo di trasformazioni religiose qui esaminate»[35].
La frequenza religiosa della famiglia gioca infine un ruolo importante e durevole nel tempo nei confronti dei figli. Uno studio in proposito evidenzia che il 61% degli adulti statunitensi che frequentava la chiesa da bambini continua tuttora a frequentarla, mentre il 45% dei bambini non praticanti continua a disertarla nell’età adulta[36].
Altri dati interessanti emergono a proposito della relazione tra istruzione e pratica religiosa. Una ricerca compiuta in Svizzera mostra il possibile legame tra paternità ed educazione religiosa: «il fattore decisivo nel determinare il passaggio della religione alla generazione successiva è la pratica religiosa del padre di famiglia. Da essa dipende, in modo pressoché totale, se i suoi figli frequenteranno o meno la chiesa. Se il padre non va in chiesa, solo un bambino su cinquanta frequenterà la chiesa da adulto, indipendentemente da quanto ci va la madre. Se il padre la frequenta regolarmente, da due terzi a tre quarti dei loro figli andranno regolarmente in chiesa, indipendentemente da quanto lo fa la madre»[37].
Non si può non ricordare infine quanto nella stessa bibbia il padre risulti importante per la vita di fede del bambino. Si pensi ad esempio alla situazione della famiglia di Gesù; in fondo, un marito e un padre non risultavano forse inutili? Il motivo della necessità di un padre, anche se putativo, non può essere individuato solo dalla consuetudine del tempo o dalla garanzia di una tranquillità esteriore, elementi d’altronde ben poco presenti in questa famiglia. Il motivo è di altro tipo, e viene sottolineato con chiarezza dall’esortazione apostolica di Giovanni Paolo II, Redemptoris custos, dedicata appunto alla figura di s. Giuseppe. Il papa vede in Giuseppe quel compito da sempre affidato al padre di introdurre il bambino nella realtà del mondo: «Gli evangelisti sono molto attenti a mostrare come nella vita di Gesù nulla sia stato lasciato al caso, ma tutto si sia svolto secondo un piano divinamente prestabilito […]. Maria è l’umile serva del Signore, preparata dall’eternità al compito di essere madre di Dio; Giuseppe è colui che ha l’incarico di provvedere all’inserimento «ordinato» del Figlio di Dio nel mondo, nel rispetto delle disposizioni divine e delle leggi umane. Tutta la vita cosiddetta «privata» o «nascosta» di Gesù è affidata alla sua custodia»[38].
Si ritrova in questo testo l’intuizione centrale che ha attraversato le riflessioni fin qui svolte a proposito del ruolo del padre all’interno della famiglia: Giuseppe esercita la sua vocazione di padre, di «assicurare la protezione paterna a Gesù» (n. 7), di «inserire il Figlio nel mondo», di custodirlo perché possa crescere, apprendere un lavoro e diventare uomo: «La crescita di Gesù “in sapienza, in età e in grazia” (Lc 2,52) avvenne nell’ambito della santa Famiglia sotto gli occhi di Giuseppe, che aveva l’alto compito di “allevare”, ossia di nutrire, di vestire e di istruire Gesù nella legge e in un mestiere, in conformità ai doveri assegnati al padre»[39].
E, in quanto padre, è chiamato da Dio a proteggere il figlio dai pericoli. È infatti a lui che l’angelo in sogno comanda di portare il bambino lontano da Erode (cfr Mt 2,13).
Va anche precisato che la crisi del padre si ripercuote naturalmente anche sulla madre. Mancando il padre, c’è il rischio che la madre investa in maniera spropositata nella relazione con i figli, soffocandoli e perdendo le distanze, chiedendo loro di riempire l’affetto che non può ricevere da un uomo.
Il punto di arrivo: la generatività
L’uomo e la donna divengono veramente adulti quando generano, dando vita a un essere distinto da loro, che li continua nel tempo. Generare richiede di «lasciar andare» l’altro, non trattenerlo presso di sé, in modo che possa prendere vita e acquisire la propria identità. Questo lasciare è anche lo scopo del compito educativo: rendere capace il figlio di autonomia e responsabilità.
La crisi della generatività non emerge soltanto dal drastico calo delle nascite; la si ritrova in quasi ogni campo dell’attività umana. Si pensi alla vita politica e sociale: sempre più di rado un uomo di governo, un leader, il fondatore di un movimento o di un’opera pubblica, per quanto brillante e dotato, si mostra capace di preparare qualcuno in grado di continuare la sua opera. È invece triste constatare come, sempre più spesso, persone molto avanti negli anni si comportino da bambini egoisti, incapaci di «lasciare spazio» perché altri possano subentrare. Essi si attaccano con morbosità al proprio incarico, al posto di comando, senza rendersi conto che è giunto il momento di «passare il testimone». Anche questa è una sconfitta educativa, forse la più grave, nei confronti delle giovani generazioni.
La generatività è anche un discernimento dei segni dei tempi: riconoscere il momento in cui è necessario farsi da parte perché altri possano proseguire l’opera intrapresa. La missione educativa può dirsi compiuta quando ha generato qualcuno in grado di continuarla. Come recita un detto orientale: «Sappi fermarti un passo prima che un altro ti dica: basta! Sappi interrompere il tuo cammino prima che un altro ti dica: basta! Sappi lasciare il posto a lungo occupato, prima che un altro ti dica: basta!».
Essere educatori come persone capaci di generare è difficile ma affascinante, è ciò che rende alla fine la vita degna di essere vissuta. È la grazia che il genitore, autore di questa preghiera, chiede al Signore, di poter rispondere degnamente al compito che gli è stato affidato, così da realizzare con il proprio figlio una relazione autentica, basata su di un amore che non è possessivo, consentendogli di occupare il suo posto nella vita:
«Io prego di riuscire a permettere a mio figlio di vivere la sua vita/e non quella che io vorrei aver vissuto./Perciò fa che non metta sulle sue spalle il fardello di ciò che non sono riuscito a fare./Aiutami a vedere oggi i suoi errori/in prospettiva della lunga strada che deve percorrere,/e concedimi la grazia di avere pazienza quando il suo passo è lento./Donami la saggezza di sapere quando sorridere delle monellerie della sua età/e quando mostrare fermezza contro gli impulsi/che egli teme e non può dominare./Aiutami a percepire l’angoscia nel suo cuore in mezzo al frastuono delle parole piene di rabbia,/o nel gorgo del suo cupo silenzio; e, dopo averla percepita,/dammi la capacità di riempire l’abisso che c’è tra noi con la comprensione./Prego di poter alzare la mia voce più per la gioia di ciò che egli è/che per il dispiacere di ciò che non è,/cosicché ogni giorno egli possa crescere nella fiducia in se stesso./Aiutami a guardare a lui con affetto autentico,/in modo che lui possa fare lo stesso nei confronti degli altri./E poi dammi la forza, o Signore, di lasciarlo libero/affinché possa andare con decisione per la sua strada»[40].
[PS: La presente relazione è tratta dai seguenti scritti: G. Cucci, La crisi dell’adulto. La sindrome di Peter Pan, Assisi, Cittadella, 2012; Id., Abitare lo spazio della fragilità. Oltre la cultura dell’homo infirmus, Milano, Ancora-La Civiltà Cattolica, 2014. A essi si rimanda per un approfondimento della tematica]
[1] Th. Radcliffe,, Perché andare in chiesa? Il dramma dell’eucaristia, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2009, 9.
[2] Cfr G. Cucci, Esperienza religiosa e psicologia, Roma-Leumann, Ldc – La Civiltà Cattolica, 2009, sopr. cap. I-II.
[3] R. Taffel, The Second Family. How Adolescent Power Is Challenging The American Family, New York, St. Martin’s Griffin,, 16-25.
[4] A. Anatrella, A., Interminables adolescences. Les 12/30 ans, Paris, Cerf-Cujas, 1988, 197.
[5] Cit. in M. Recalcati,«Dove sono finiti gli adulti?», in la Repubblica, 19 febbraio 2012.
[6] H. Bruch, La gabbia d’oro. L’enigma dell’anoressia mentale, Milano, Feltrinelli, 2003, 14.
[7] A. Oliviero Ferraris, La sindrome Lolita. Perché i nostri figli crescono troppo in fretta, Milano, Rizzoli, 2008, 179.
[8] A. Beria di Argentine, «La sofferenza, meglio non parlarne», in Corriere della sera, 6 marzo 1986.
[9] Ivi.
[10] Cfr H. Kaplan – B. Sadock, Psichiatria, Torino, Centro Scientifico Internazionale, 2001, vol. 2, 1250.
[11] Cfr P. Crepet, Le dimensioni del vuoto. I giovani e il suicidio, Milano, Feltrinelli, 1993, 36-37.
[12] U. Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, Milano, Feltrinelli, 2007, 28; cfr M. Benasayag – G. Schmit, L’epoca delle passioni tristi, Milano, Feltrinelli, 2005.
[13] U. Galimberti, «Noi, malati di tristezza», in la Repubblica, 1 giugno 2004.
[14] A. Anatrella, A., Interminables adolescences…, cit., 189.
[15] G. Pietropolli Charmet – A. Piotti (eds), Uccidersi. Il tentativo di suicidio in adolescenza, Milano, Cortina, 2009, 43.
[16] «Oggi i bambini vengono iniziati, fin dalla più tenera età, alla fisiologia dell’amore e della nascita, ma, quando non vedono più il nonno e chiedono perché, in Francia si risponde loro che è partito per un paese molto lontano, e in Inghilterra che riposa in un bel giardino dove cresce il caprifoglio. Non sono più i bambini a nascere sotto un cavolo, ma i morti a scomparire tra i fiori. I parenti dei morti sono quindi costretti a fingersi indifferenti. La società esige da loro un autocontrollo che corrisponde alla decenza o alla dignità imposta ai moribondi. Nel caso del morente, come in quello del superstite, importa soprattutto non lasciar trasparire in alcun modo le proprie emozioni» (Ph. Ariès, Storia della morte in occidente. Dal medioevo ai giorni nostri, Rizzoli, Milano 1978, 213-214).
[17] Cit. in E. Drewermann, Psicanalisi e teologia morale, Brescia, Queriniana, 2005, 317-318.
[18] J. Savage, J., L’invenzione dei giovani, Milano, Feltrinelli, 2009, 472.
[19] Pipher, in M. Mead, L’adolescenza in Samoa, Firenze, Giunti, 2007, XV.
[20] M. Gauchet, Il figlio del desiderio. Una rivoluzione antropologica, Milano, Vita e Pensiero, 2010, 43.
[21] N. Postman, La scomparsa dell’infanzia, Roma, Armando, 1984, 156.
[22] Conferenza Episcopale Italiana, Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio 2010-2020, 4 ottobre 2010, n. 6.
[23] Benedetto XVI, Lettera alla Diocesi e alla città di Roma sul compito urgente dell’educazione, 21 gennaio 2008.
[24] P. Berger, Il brusio degli angeli, Bologna, il Mulino, 1969, 92.94.
[25] A. Grün, Autostima e accettazione dell’ombra, Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 1998, 16; cfr Conferenza Episcopale Italiana, Educare alla vita buona del Vangelo…, cit., nn. 27-28.36-38.
[26] F. Ladame, Gli eterni adolescenti, Milano, Salani, 2004, 151.
[27] M. Eliade, M., La nascita mistica. Riti e simboli d’iniziazione, Brescia, Morcelliana, 1974, 24.
[28] Cfr M. Segalen, Riti e rituali contemporanei, Bologna, il Mulino, 2002 34-35; 46-53; A. Van Gennep, I riti di passaggio, Torino, Boringhieri, 1981, 167; N. Mandela, Lungo cammino verso la libertà, Milano, Feltrinelli, 2010, 36-39.
[29] Cfr Ch. Ullman, The Transformed Self. The psychology of Religious Conversion, New York-London, Pelnum Press, 1989, 50-56; . G. Cucci, Esperienza religiosa e psicologia, cit., 79-98.
[30] A. Philips, I no che aiutano a crescere, Milano, Feltrinelli, 1999, 65.
[31] Cfr A. Deutsch, «Observations on a sidewalk ahsram», in Archives of General Psychiatry 32 (1975), 166-174; L. Kirkpatrick, «A longitudinal study of changes in religious belief and behavior as a function of individual differences in adult attachment style», in Journal for the Scientific Study of Religion 36 (1997) 207-217.
[32] L. Zoja, Il gesto di Ettore. Preistoria, storia, attualità, scomparsa del padre, Torino, Boringhieri, 2000, 113-114; cfr Odissea, XVI, 148-149.
[33] L. Zoja, Il gesto di Ettore…, cit., 305; cfr Odissea, XXI, 404-410.
[34] Cfr D. B. Lynn, The Father; His Role in Child Development, Monterey, Brooks/Cole 1974.
[35] Cfr Ch. Ullman, The Transformed Self…, cit., 45.
[36] G. Barna, «Adults Who Attended Church As Children Show Lifelong Effects», in www.barna.org.
[37] C. Risé, Il padre. L’assente inaccettabile, Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 2003, 34-35. Dati molto simili emergono da R. Low: «Se il padre ha una frequenza irregolare e la madre costante, solo il 3% dei figli sarà costante, e per il 59% sarà anch’esso irregolare. Il 38% abbandonerà. Se il padre non è praticante e la madre frequenta regolarmente, solo il 2% dei figli frequenterà in modo regolare il precetto festivo, il 37% frequenterà in modo irregolare, mentre più del 60% abbandonerà del tutto la pratica religiosa» (R. Low, «The Truth About Men & Church», Touchstone, June 2003).
[38] Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Redemptoris custos, 15 agosto 1989, n. 8. Cfr Origene, Om. XIII in Lucam, n. 7.
[39] Ivi, n. 16. Cfr C. Risé, Il padre…, cit., 41-43.
[40] Cit. in P. Andrews, «Le tappe e le insidie del crescere. Gli adolescenti in Irlanda», in La Civiltà Cattolica 1993 II 578.